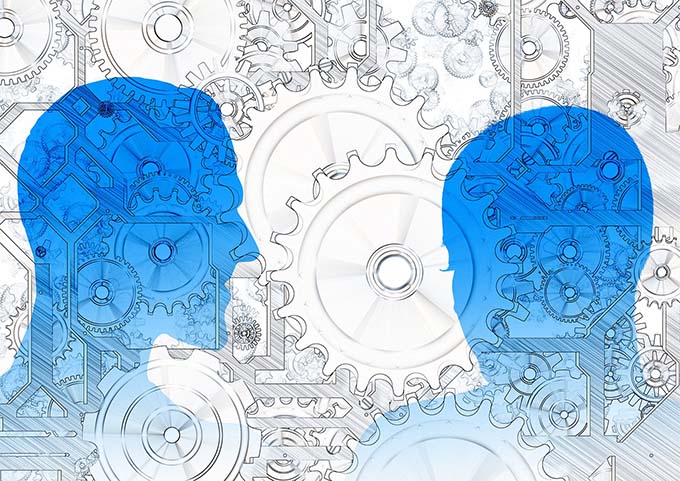di GIAMPIETRO DE ANGELIS –
 Il tristissimo episodio di Giulia Cecchettin – triste proprio perché assurdo, inaccettabile nella sua drammatica dinamica – sta aprendo molte discussioni, anche nuove rispetto al passato. Dopo il richiamo della sorella Elena a fare “rumore” più che silenzio e interrogarci, soprattutto noi uomini, su ciò che siamo e con quale percentuale di cultura patriarcale conviviamo, faccio la mia parte. Mi interrogo. O meglio, rifletto. Riporto la mia memoria a circa 35 anni fa: giovane padre accompagna all’asilo il figlio di quattro anni. Rivedo le scene come fossero vissute oggi. Ci sono padri e madri, inevitabilmente. Si parla in attesa che i bambini escano, si osserva l’osservabile. E così, mentre qualcuno, come chi scrive, lascia la propria auto più lontano che può per lasciare spazio davanti all’istituto, c’è chi arriva frettoloso e quasi blocca il passaggio del cancello. Iniziamo da qui, dall’imporre la propria presenza, con il significato non tanto subliminale che gli appartiene: conto più di te.
Il tristissimo episodio di Giulia Cecchettin – triste proprio perché assurdo, inaccettabile nella sua drammatica dinamica – sta aprendo molte discussioni, anche nuove rispetto al passato. Dopo il richiamo della sorella Elena a fare “rumore” più che silenzio e interrogarci, soprattutto noi uomini, su ciò che siamo e con quale percentuale di cultura patriarcale conviviamo, faccio la mia parte. Mi interrogo. O meglio, rifletto. Riporto la mia memoria a circa 35 anni fa: giovane padre accompagna all’asilo il figlio di quattro anni. Rivedo le scene come fossero vissute oggi. Ci sono padri e madri, inevitabilmente. Si parla in attesa che i bambini escano, si osserva l’osservabile. E così, mentre qualcuno, come chi scrive, lascia la propria auto più lontano che può per lasciare spazio davanti all’istituto, c’è chi arriva frettoloso e quasi blocca il passaggio del cancello. Iniziamo da qui, dall’imporre la propria presenza, con il significato non tanto subliminale che gli appartiene: conto più di te.
Questo atteggiamento, a dire il vero e soprattutto nell’oggi, lo vediamo tanto negli uomini quanto nelle donne, ma volendo – giustamente in questo contesto – soffermarci all’emisfero maschile, vien da dire che qui la “mascolinità” ha termini precisi: arroganza, presunzione, senso di vittoria, competitività. Non c’è da vincere nulla, ovviamente, ma l’atteggiamento è quello, mostrare qualcosa, mostrare i muscoli, reali o metaforici. Un genitore che conoscevo, e che sembrava una gran brava persona, candidamente diceva che al figliolo, di quattro anni come il mio, insegnava a “menare” per primo alla primissima impressione che qualcosa non era nel verso giusto, a suo insindacabile giudizio quindi. Diceva questo a me, proprio a me che insegnavo, anche con l’esempio oltre che con le parole, di non provocare risse, di non “menare” – per mantenere il gergo – né per primo né per secondo. Quindi mai. Il figlio di quel signore vien da sé che era un attabrighe.
Ecco, siamo figli di quello che abbiamo vissuto, in una certa e alta percentuale. Siamo figli della cultura che abbiamo visto in casa come fuori. Soprattutto in casa. E se un tempo la cultura dominante era quella patriarcale, oggi è quella della prestazione competitiva, che ci spiazza. O meglio, spiazza il fragile. Spiazza coloro non abituati ad analizzare nel profondo, coloro che non sanno accettarsi per quello che sono, che non sanno amare le proprie debolezze, né metabolizzare un rifiuto. Sono persone che non sanno perdere, psicologicamente parlando, e questo è l’aspetto più pernicioso perché quando non si sa affrontare la sconfitta, accettandola o analizzandola per una nuova visione costruttiva, si ha bisogno di riscatto e rivincita, che sono intenzioni di guerra nei rapporti umani. Sono intenzioni di guerra che scavano interiormente, covano, preparano all’attacco quando ancora, in superficie, sembra tutto – o quasi – normale.
Siamo figli di quello che respiriamo ma come in un pianeta dove occorrerebbe un altro impianto respiratorio. Siamo fuori tempo, fuori fase. Siamo fuori umanità. La cultura patriarcale, ma meglio parlare di atteggiamento competitivo e dominante, risulterebbe ininfluente se ci fosse una buona cultura umanistica che invece è sempre carente, sempre un passo indietro. Sarebbe ininfluente se ci fosse un forte senso spirituale che è praticamente assente, talvolta anche nelle religioni. E sarebbe ininfluente se nella vita del singolo ci fosse un buon equilibrio psichico, la saggezza del “Sé”. È la costruzione di questa saggezza che spesso è assente. Imparare ad osservarsi da dentro per sapersi rapportare al fuori non è materia d’insegnamento. In chi non sa trovare gli strumenti giusti il proprio malessere viene autoalimentato, ingigantendo le frustrazioni e travisando il reale, preparando il terreno alla battaglia, ovvero ad un malato rapporto interpersonale. Già in condizioni ottimali si fa fatica ad interpretare il reale, figuriamoci in condizione di fragilità psicologica.
Per riassumere, chi non sa perdere non sa neanche amare. L’amore non ha mai (e mai significa mai) la forza della volontà e del dominio, l’amore è sempre rapportato all’empatia e al desiderio del bene superiore, quello dell’altra persona. Nel mio caso? Debbo ringraziare anni di praticantato yoga e sedute di meditazione, oltre all’approfondimento della spiritualità nelle cose della vita, per avermi insegnato l’accettazione e la sperimentazione della sconfitta. Solo accogliendola possiamo costruire qualcosa di più bello evitando le tensione della frustrazione cocente, riuscendo anche a superare indenne l’influsso mediatico e il bombardamento pubblicitario, nonché l’oppressione del marketing nell’imporre modelli sociali.
Copyright©2023 Il Graffio, riproduzione riservata