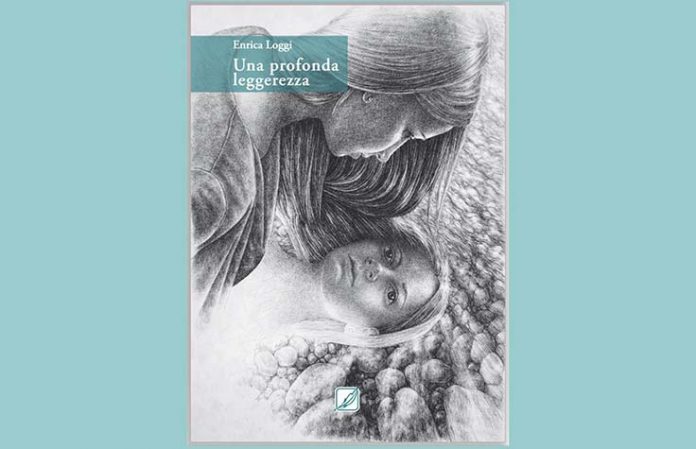di LUANA TRAPÉ –
ENRICA LOGGI – Poemetto della neve (A mia sorella Marisa)
 Fin dai primi versi la cadenza segue l’andare di un pendolo che tesse la materia del canto, oscillando tra due poli antitetici e complementari: il sogno che debordava nella veglia e viceversa, poiché la frontiera che li separa è permeabile nelle due direzioni, lascia passare messaggi, rimandi e interferenze. Come la realtà contribuisce a formare e nutrire il sogno, così esso fa baluginare parvenze di figure vere.
Fin dai primi versi la cadenza segue l’andare di un pendolo che tesse la materia del canto, oscillando tra due poli antitetici e complementari: il sogno che debordava nella veglia e viceversa, poiché la frontiera che li separa è permeabile nelle due direzioni, lascia passare messaggi, rimandi e interferenze. Come la realtà contribuisce a formare e nutrire il sogno, così esso fa baluginare parvenze di figure vere.
Tra territori sconosciuti e luoghi noti, tra certezze e dubbi, tra figure evanescenti e altre concretamente definite, convocando la sorella scomparsa si aggira l’autrice in una remota lontananza che accomuna il sogno al regno delle ombre, dove gli antichi situavano i defunti. Nell’atmosfera sospesa creata dalla neve la possibilità di un contatto tra le due donne – seppure instabile e oscillante – si compone per figurazioni e metafore. Marisa, pensata come neve, ne impersona l’indeterminatezza per il tramite di figure retoriche dell’antitesi, in particolar modo l’ossimoro, coniugato tra vari opposti: nitido/vago; ghiaccio/caldo; chiaro (bianco, neve, luce) spesso lambito dal suo antagonista: l’oscurità (fuliggine, notte, clausura).
Così l’amore che lega le sorelle si accompagna per consonanza ad “amara” e poi, per attrazione, all’avversa stagione.
Il ghiaccio, come una rozza trina bordato di fuliggine, di prepotenza si allunga a funestare la delicata similitudine successiva
Così sei in questo giorno, un merletto
con mani svelte, su un lenzuolo da sposa.
Come sempre attenta ai colori e alle atmosfere, Enrica Loggi costruisce il senso della morte durante un pellegrinaggio tra immagini, suoni, gesti, in una visione sfuggente: il paesaggio indefinito fa perdere l’orientamento, le strade scorrono una nell’altra, tra l’immenso biancore e i mesi impolverati, i movimenti tardi, l’incapacità dei personaggi di formulare parole, nel fluire di una scena cinematografica che bene esprime lo stato d’animo del sogno come cifra dell’assenza.
chi passava era lento come il tempo
e passava
il bambino incappucciato per il gelo
la madre che gli dava la mano, un’unica solitudine.
Sorella, le voci erano ghiacce
e calde, come se nessuno
sapesse più parlare, nell’enigma bianco
che lo stringeva.
Enigma presto svelato nell’accezione fatale del bianco come ghiaccio che imprigiona e soffoca la vita. Inizia ora una cantata funebre della rievocazione: un “epicedio”, nell’antichità accompagnato dal flauto, mentre qui è un suono di oboe
che percorre le balze dei paesi
danzando sopra le miserie.
Il canto memoriale riesce ad oggettivare i pensieri nella loro essenza sensibile, come l’apparizione della sorella nella sua casa
a reggere questa coperta ruvida
e candida della tua vita.
Un ossimoro intenso per sinestesia tatto/vista – restituisce le discordanze della vita, ché il “candido” suggerirebbe piuttosto la morbidezza.
Tu sei di neve, io ti sono accanto.
Vicinanza illusoria e fallace, come effimera è la neve, poiché la sorella è già oltre il cancello, chiusa, sommersa nel mondo da cui non si ritorna. Infatti la poetessa – pur facendo rivivere intatte le presenze del passato grazie all’immaginazione creativa, pur potendo parlare a Marisa, incarnata in una tangibilità corporea – non può sforzare la sua natura ormai intoccabile di fantasma, seppur magnifico, che a fiocchi lacrimava sul mondo.
Tuttavia il viaggio poetico le permette di avvicinarsi alla casa di lei: un luogo della memoria cui attingere in qualsiasi momento, sia pure in forma onirica: qualcosa che c’è e non c’è, esiste e non esiste. Circondarsi di un mondo visibile crea un effetto mnemonico potentissimo; così le è possibile immaginare di vedere il sorriso della sorella dietro le tende al di là della barriera dei vetri, nelle stanze dove i ripari dell’anima sono al sicuro, trovando il tesoro che ci è stato rubato; e dura l’illusione che
perdendoti per molti giorni,
avrei ritrovato le tue orme
quelle della neve gelata,
che i cani leccano per dissetarsi.
Il cane e il gatto, creature che qui con gli esseri umani condividono sete e lacrime, sono figure di “paredri”, i custodi che “ci siedono accanto” e ci confortano nella quotidianità, esseri familiari e insieme enigmatici numi tutelari, custodi in segreto del portato simbolico di antichi miti.
Ogni volta che un poeta affronta un mito, lo rinnova e lo invera. S’inoltra dunque la protagonista lungo la stessa via di quei personaggi letterari che battono alle porte dell’Ade: mitiche figure anelanti che inseguono e altre che sono inseguite, prima di tutto Demetra, alla ricerca della figlia Persefone ormai divenuta regina dell’Ade. A questa si rivolse Orfeo e, affascinandola con il canto, ottenne il privilegio di far tornare al regno dei vivi Euridice, la sposa defunta.
Simile ad Orfeo, con il viso cosparso di bianca calce come anticamente avveniva durante i riti funebri, Enrica si fa minuscolo aedo e con versi rammemoranti serra ed apre a un’altra riva del mondo, schiudendo uno spiraglio per evocare la sorella e ricondurla a sé.
Il viaggio di Euridice non doveva finir bene: Rainer M. Rilke la dipinge mentre emerge “malcerta” verso la luce, condotta da Hermes, “i due dal lentissimo passo”, “taciturni” (come la mamma e il bambino in questo poemetto); e quando il dio esclama con dolore che Orfeo – trasgredendo i patti inferi – si è voltato, lei chiede trasognata: “Chi?”
Perché i defunti non sanno più nulla, non ricordano gli amati messaggeri del mondo, e sono riluttanti a ripetere all’inverso il cammino faticoso della vita, né possono rispondere a chi li interroga.
adesso è tardi per tornare
sui passi ormai invisibili …
… Mi riconosci?
Sono io, vengo dalla strada …
… Ti faccio paura?
… Ma tu non puoi vedere, sei tutta col mio racconto.
non è per me il rimpianto.
I versi hanno dato un corpo al fantasma, il monologo desiderante ha restituito voce al silenzio di chi è ormai senza parola, donato parole al lutto. La separazione è senza dubbio fatale, l’assenza irrimediabile, ma il lettore non è condotto alla disperazione. La poesia infatti, convocando in presenza la persona perduta, la fa esistere di nuovo; così si attua la persistenza di ciò che non è più. Il passato si compone con il presente, o piuttosto deborda in esso: prende forma, colore e suono, trasfigurato dalla dolorosa meditazione sull’esistenza.
Canto il tempo lungo del tuo silenzio
Copyright©2021 Il Graffio, riproduzione riservata